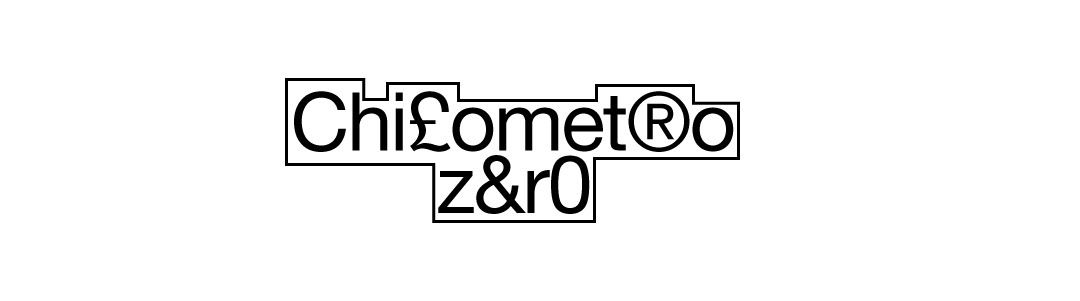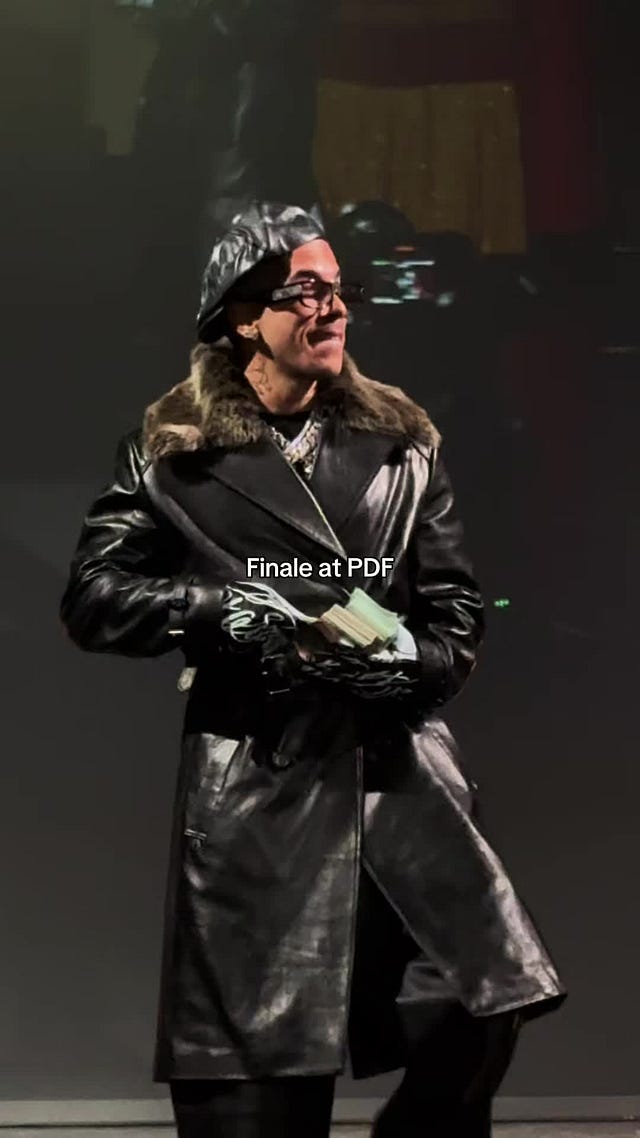🇮🇹 Un'analisi critica della Milano Fashion Week – Cool Haunted by nss magazine
Una settimana anemica che ci ha fatto domandare: «Cos’è che ci è piaciuto veramente?»
La frase che apriva le show note di Prada, questa stagione, era «Cosa siamo in grado di creare partendo da quanto già conosciamo?». Potrebbe essere presa come commento generale a tutte le sfilate che abbiamo visto nel corso di questa Milano Fashion Week FW26. Certo, bisognerà sicuramente attendere la settimana femminile per vedere i veri fuochi d’artificio, ma nel corso di questo lungo weekend è parso abbastanza chiaro che, per molti brand, il menswear sia un campo da gioco piuttosto limitato.
Il problema, sembrerebbe, è che nessun brand che mostra a Milano si sia domandato onestamente come gli uomini si vestano nella vita quotidiana. Con le dovute eccezioni, il pendolo ha oscillato invariabilmente tra gli abiti formali e lo streetwear più canonico immaginabile. Ci sono state pochissime sfumature del guardaroba Old Money e di una serie di progetti classificabili da qualche parte tra la moda algoritmica di TikTok, il dilettantesco e il performativo.
Come molti hanno già notato, il calendario spopolato dai grandi nomi ha lasciato ampio spazio a una serie di esordienti, sia italiani che non, che sono stati particolarmente meritevoli e che con maggior sostegno potrebbero presto fare di Milano una nuova fucina creativa.
Ma quindi cosa ci è piaciuto di questa Milan Fashion Week?
I tre brand che sono emersi meglio da questa Milan Fashion Week non rappresentano alcuna corrente avant-garde: al contrario, hanno avuto in comune una disinvolta sicurezza nel gestire la tradizione e una certa freschezza di pensiero nel rinnovare il già noto, senza però ripeterlo. I brand in questione sono stati Zegna, Ralph Lauren e Paul Smith, tutti nomi storici del menswear, tutti percepiti come classici ma, al contempo e proprio per questo, tutti e tre capaci di offrire un deciso senso di freschezza che è stato il derivato della loro onestà: nessuna torsione intellettuale, nessuna autoindulgenza, nessun pastrocchio amatoriale fatto passare per arte.
Un altro elemento comune a tutti e tre è stato il grande senso di precisione e la lucidità con cui queste collezioni erano concepite. Da Zegna, pur sotto i colori terrosi e generalmente scuri di un guardaroba d’antan, le costruzioni di giacche, capispalla e completi erano assolutamente moderne, mai démodé, anzi. Ralph Lauren, invece, si è riappropriato di quell’estetica sovrabbondante e vivace che brand come Aimè Leon Dore avevano co-optato già da qualche tempo, aggiornandola, e riaffermandosi come il grande signore dell’estetica USA in un momento in cui il mito americano a cui il mondo è affezionato si sta decomponendo in tempo reale nei sempre più rapidi cicli di news online.
Infine, Paul Smith, designer di grandissimo successo ma situato al di fuori delle dinamiche della moda tradizionale, privo di un preciso segno distintivo, ha portato a segno una collezione semplicemente indovinata. Le proporzioni erano giuste e fresche con un’inclinazione al giovanilismo, lo styling sobrio ma efficace, lo stile chiaro e netto ma scanzonato privo di pesantezze o forzature. Era, in breve, agilità ed esattezza pura - che è molto più di quanto ci sia stato offerto altrove.
Un altro tipo di moda che si vede solo a Milano è quella vistosa, pop e festaiola di Dsquared2 e Dolce&Gabbana. Due brand, ciascuno diretto da un iconico duo, che hanno in comune una spinta verso una moda enfatica, molto vitale, che non va per il sottile nemmeno come quando, ad esempio, nello show di Dolce&Gabbana, si popola di completi grigi e abiti da sera. Entrambi i brand si basano su un senso di machismo che rimanda a un archetipo umano forse un po’ superato nella sua ostentazione di presunta superiorità e sicurezza.
Al netto di queste caratteristiche (c’è chi ha criticato fortemente le scelte del casting), la moda che questi due brand continuano a proporre e il format con cui la propongono sono piacevolmente privi di quel senso di sostenutezza e snobismo che regna in altre e incensate case. Potremmo definirla “himbo fashion”? È una moda che vuole l’eccellenza ma non teme la frivolezza, che è energetica e popolare e in cui la sfilata diventa spesso parata.
Muovendosi verso terreni più ricercati, non si possono non notare gli esordi di nomi relativamente nuovi per la programmazione milanese. Non tutti i brand in questione sono esordienti assoluti, anzi lo sono solo Victor Hart e Domenico Orefice, perché gli altri due, Setchu e Qasimi, hanno già diverse stagioni alle spalle. Ma tutti e quattro i marchi sono riusciti a portare cose nuove in passerella.
Se da Qasimi a vincere è stata la misura dei colori e la fedeltà al tema ricorrente dei mantelli e dei drappeggi che trasfiguravano la classica uniforme sartoriale, è stato Satoshi Kuwata di Setchu ha complicare davvero le cose con una collezione molto (forse troppo?) densa di dettagli che, visti anche solo in foto, possono sembrare confusionari ma costruiti con profonda intelligenza.
Invece, sia Victor Hart che Domenico Orefice hanno funzionato bene grazie a un forte senso di autoconsapevolezza. Entrambi i designer sanno cosa sono e cosa vogliono fare. Il che si traduce da un lato nei volumi scolpiti nel denim di Victor Hart, dall’altro nel guardaroba scattante e fresco di Domenico Orefice, la cui proposta, più matura di stagione in stagione, ha una direzione molto netta ma immediata e comprensibile.
Il meglio che Milano ha da offrire in termini di inventiva ma soprattutto di attualità sono i designer italiani protagonisti delle presentazioni alla Fondazione Sozzani. Certo, potrebbe sicuramente aiutare per il futuro che questi emergenti e indipendenti non finiscano letteralmente confinati nella decentratissima Fondazione Sozzani, e che magari potessero invece essere ospitati in location più adatte come ad esempio il Palazzo dei Giureconsulti che in passato è stato prestato a funzioni assai meno nobili, incluso un pop-up di Shein.
Si va dalle fluenti stratificazioni di tessuto di Maragno, che questa stagione aveva in mente un immaginario nomadico, fatto di cumuli di pelliccia e linee morbide; fino all’acido, scandinavo pragmatismo di Rold Skov, che sembra la risposta italiana ai vari Our Legacy e Berner Khul. Più eterei, Pecoranera e PLĀS Collective hanno presentato interessanti esperimenti con la maglieria seguendo, il primo, una direzione teatrale e drammatica, con lunghi abiti di maglia, dettagli quasi scolpiti nel tessuto, colletti e corsage realizzati del tutto in maglia; e optando invece il secondo per un mood più leggero, decorativo e femminile.
Il più interessante di tutti, però, rimane il sardonico e quasi decadente Meriisi, che evoca atmosfere da rocker con un senso del vintage tutto italiano e un gusto quasi diabolico per un vestiario idiosincratico. Per questa collezione, il brand ha mescolato al classico chiodo di pelle una maglietta di Toy Story, ha applicato ai pantaloni di lana una zip esposta che evidenziava l’inguine, oppure ha dotato la maglieria di cristalli, ricami e un senso dell’ironia che praticamente implora di esprimersi su una passerella.
Se la settimana si è aperta con la sublimazione e rielaborazione della tradizione sartoriale di Zegna, la chiusura di PDF è parsa come il segno dei tempi. Il brand fondato da Domenico Formichetti è il portavoce di una generazione di italiani nuova, più multiculturale, cresciuta con il mito dell’hip-hop americano e per cui lo stile personale non riguarda l’elaborazione estrema di un artigianato ma la dichiarazione più lampante e meno sottile possibile di un nuovo tipo di aspirazionalità.
 Tiktok failed to load.
Tiktok failed to load.Enable 3rd party cookies or use another browser
Nello show di Formichetti gli abiti acquisivano senso e peso estetico come oggetti di scena di una narrazione teatrale in cinque atti che faceva delle convenzioni narrative del classico gangsta rap un gioco di ruolo per una gioventù borghese che coltiva comunque il mito della strada, delle armi, delle faide tra bande, dei soldi facilmente guadagnati e facilmente sparsi ai quattro venti.
Ed è indicativo, infine, che allo show di PDF fosse presente una community non di “very important client” altezzosi e arrivati dai quattro angoli del pianeta, ma di veri appassionati del brand, mescolati alla stampa e ai buyer in una ressa che, come un giornalista più stagionato ricordava all’ingresso, non era troppo distante da quella delle sfilate negli anni ’80. Ed è dunque la chiusura di un cerchio o l’apertura di un nuovo ciclo? Ce lo chiediamo, domandandoci anche se Milano saprà adattarsi ai tempi che cambiano.